
Il tema della ‘domesticazione umana’ era già stato introdotto in un mio precedente post, ma credo valga la pena di svilupparlo meglio perché consente di inquadrare nella giusta prospettiva fenomeni che risultano ‘inspiegabili’ con le chiavi di lettura attuali. Ancora ieri si ragionava di incidentalità stradale, dell’aggressività alla guida, dell’insufficienza nelle reazioni messe in atto nel corso degli anni (campagne informative inefficaci o totalmente sbagliate, mancato adeguamento della legislazione e via dicendo…), con diverse persone che sottolineavano l’incomprensibilità di certi accadimenti.
Per approcciare la questione va fatto un lungo passo indietro, fino al lunghissimo arco di tempo (dal 15.000 al 4.000 a.C.) nel corso del quale l’Homo Sapiens ha addomesticato altre specie animali e vegetali, selezionando le varietà più utili e sostanzialmente stravolgendo il genoma di una porzione importante della biosfera.
La domesticazione coinvolge aspetti diversi. Nelle piante quello che si ricerca da principio è la produttività. Le piante da frutto utilizzano gli animali per massimizzare la diffusione dei propri semi (i frutti vengono mangiati ed i semi ‘diffusi’ assieme alle feci su un areale più vasto, passando indenni attraverso i processi digestivi). L’umanità seleziona le varietà con i frutti più grossi e gradevoli, e ne crea coltivazioni intensive.
L’esito finale può essere disastroso per la specie domesticata. Nel grano originario, ad esempio, i semi si staccano spontaneamente dalla spiga cadendo a terra per la semina dell’anno successivo. Ma questo non è funzionale alle esigenze umane, cosicché nel tempo si sono selezionate varietà di grano nelle quali i semi non si staccano. Varietà che non avrebbero modo di sopravvivere nell’ambiente senza l’intervento umano.
Con gli animali si sono prodotte dinamiche analoghe. Gli animali, a differenza delle piante, devono adattarsi alla vita in cattività, cosa non scontata. Jared Diamond spiega che alcune specie non sopportano di venir rinchiuse in recinti, si scagliano contro le pareti tentando di fuggire fino a morirne. Altre specie si adattano alla prigionia ma non si riproducono in cattività, cosa che rende impraticabile l’allevamento.
L’animale che per primo fu domesticato fu il lupo, utilizzato dai nostri antenati come aiuto nella caccia ed in seguito sottoposto ad una infinita serie di selezioni arbitrarie fino a produrre tutte le varietà esistenti di specie canine, dall’alano al chihuahua passando per bassotti, levrieri, molossi e barboncini.
La nostra stessa specie non è passata del tutto indenne attraverso questa fiera delle mostruosità, nonostante gli adattamenti prodotti nel tempo siano di natura più psicologica che morfologica. L’umanità nasce come una specie di cacciatori-raccoglitori nomadi che, in seguito all’invenzione dell’agricoltura, diviene stanziale, comincia ad intervenire sull’ambiente circostante su larga scala, crea comunità numerose e dà infine vita agli aggregati chiamati città.
L’esistenza delle città dipende dall’accettazione della coesistenza fra centinaia, poi migliaia, di individui. Questo è il primo adattamento psicologico richiesto: la capacità di convivere in gruppi estremamente numerosi, di essere circondati costantemente da sconosciuti, di entrare in relazione con essi attraverso un linguaggio comune, convinzioni comuni, ideologie condivise. Le città nascono grazie al potere militare che sono in grado di esprimere nei confronti delle popolazioni circostanti e sono tenute unite da religioni ed ideologie.
Il faticoso adattamento alla vita collettiva, agli spazi chiusi, trova come contraltare una maggior sicurezza, la protezione di un esercito, l’abbondanza di cibo rispetto a quelli che restano a vivere isolati nelle campagne, a contatto con la natura. Gli individui che mal sopportano questa forzatura diventano viaggiatori, esploratori, mercanti, avventurieri, gli altri ingrossano le fila dei ‘residenti’, vivono vite sicure e tranquille e si riproducono a ritmi molto elevati.

Questo processo ha condotto, nel corso dei millenni, ad una mutazione antropologica di una parte consistente (numericamente maggioritaria) della nostra specie. Veniamo allevati in cattività, abituati fin da subito a vivere circondati da barriere protettive (le mura di casa, della scuola, gli abitacoli dei veicoli con i quali ci spostiamo), fino a perdere, in tutto o in parte, la familiarità con l’ambiente naturale dal quale abbiamo avuto origine.
Questo sradicamento, questa alienazione, quest’esperienza di vite sempre più artificiali verso cui la modernità ci spinge, disarticola la nostra stessa cognizione del mondo. Se le civiltà del passato erano ancora in grado di collocare sé stesse all’interno di un sistema naturale, di percepire i cicli e le esigenze della vita sul pianeta, la nostra cultura se ne è allontanata a tal punto da renderne i segnali d’allarme indecifrabili.
Così, mentre catastrofi epocali avanzano di giorno in giorno, la desertificazione (solitamente di natura antropica) erode i continenti, l’atmosfera si surriscalda a causa delle tonnellate di gas serra rilasciate quotidianamente, gli oceani si acidificano, i ghiacciai millenari si sciolgono, le specie viventi selvatiche si estinguono in massa, l’umanità non riesce a vedere oltre i confini dei recinti nei quali si è spontaneamente rinchiusa, delle gabbie in cui si è abituata a vivere e che diventano via via più strette ed opprimenti.
Come gli allevamenti industriali hanno progressivamente sostituito i pascoli, così le città contemporanee hanno sostituito quelle antiche, incrementando l’isolamento individuale grazie anche al cambiamento degli stili di vita. Rispetto al passato abbiamo città e case più ingombre di oggetti e passiamo molto più tempo in compagnia di macchine da intrattenimento che non coi nostri simili.
Negli allevamenti industriali gli animali sono compressi in spazi ridotti, mutilati per impedire aggressioni reciproche, sovralimentati per farli aumentare rapidamente di peso prima della macellazione. Gli ‘allevamenti umani’ della società consumista non sono molto dissimili, anche se rispondono ad una logica leggermente diversa. ‘Dobbiamo produrre, dobbiamo consumare’: questo è il valore degli individui all’interno del meccanismo. Più produciamo, più consumiamo, più plusvalore i nostri governanti (politici, ma sempre più spesso economici) riescono a ‘mungere’ per sé.
Lo stress urbano, l’aggressività, la violenza, sono figlie della cattività, del vivere gomito a gomito con migliaia di sconosciuti, della compressione delle nostre esigenze di spazio, silenzio, solitudine e libertà. Esigenze di cui siamo stati privati per un arco di tempo talmente lungo da non renderci più in grado neppure di riconoscerle, o dargli un nome. Un vivere quotidiano talmente opprimente da non lasciarci le capacità mentali per guardare oltre, per vedere un pianeta in lento e progressivo disfacimento. Men che meno le energie per invertire la rotta.
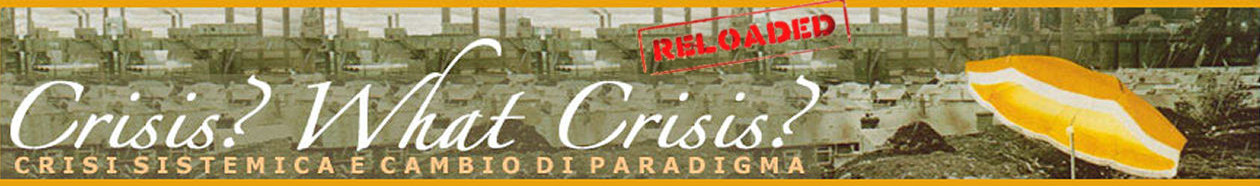

L’umanità riesce eccome a vedere oltre i confini dei recinti nei quali si è spontaneamente rinchiusa, visto che tu e molti altri parlate di questi temi: però la maggioranza degli uomini è troppo legata alle piccole comodità quotidiane per cambiare i propri comportamenti, nefasti se attuati da miliardi di persone! Ci vorrebbe un potere forte, autoritario e non democratico per cominciare a cambiare…
Pochi singoli individui non sono “l’umanità”.
E il potere “non democratico” c’è già ed è quello che ha prodotto questa situazione.
Sorry!
Il “Potere forte e riformatore” si è visto parecchie volte nella storia e di solito finisce molto male.
Marco, ho sempre ammirato il tuo modo di scrivere, ma questa volta sei stato fantastico. Le cose che scrivi sono verissime. Io le ho sempre sentite di pancia ma non le avevo mai messe a fuoco, leggerti è stato illuminante.
Ti ringrazio! 🙂
Bravissimo Marco! Mi viene in mente un’altra similitudine: l’ homo domestiscus non riesce più a sopravvivere senza dosi massicce di antibiotici, esattamente come gli animali di allevamento.
Ecco come l gente sentiva una volta, e come ancora alcuni sentono. Non è “pensare”, è “sentire”.
La città ha ucciso questo sentire.
:
Gli occhi dell’aquila sono in me.
E la mitezza della lepre è in me.
E la velocità del cervo è nelle mie gambe.
La dolcezza dello zucchero d’acero è nella mia bocca.
Anche la forza dell’orso è in me.
Il colore del fagiano è nella mia pelle.
Il grido della folaga del nord è sulla mia lingua.
Il tambureggiare della starna è nelle mie mani.
E anche il silenzio dei pini silvestri è in me.
E improvvisamente lo riconobbi: tutti questi
sono i segni del Chippewa(Ojibway) in me.
Connie Strong-
che dire, come al solito la scrittura è agile e interessante…ottimo il pensiero, anche se qualcuno le energie per (provare) a cambiare rotta ce le ha. pochi forse, ma qualcuno c’è 😉
Davvero una lettura che apre finestre nella testa, congratulazioni.
L’unica critica che mi sentirei di fare è che l’aggressività e la violenza non sono un prodotto della domesticazione, semmai questa (nell’uomo come nelle altre specie) le ha considerevolmente ridotte. Era necessario per far sopravvivere milioni di persone ammucchiate le une sulle altre.
Piuttosto direi che l’ambiente urbano è frustrante e questo può anche condurre, fra la altre cose, a scoppi di violenza inconsulta anche fra animali domestici.
La domesticazione non ha ridotto l’aggressività, semmai l’ha repressa e confinata in ambiti specifici. Penso agli eccessi delle tifoserie calcistiche, alla spettacolarizzazione cinematografica della violenza, al fenomeno delle ‘gang’ giovanili oltreoceano. Ma è una violenza, per quanto mantenuta sottopelle che emerge, quando può, spesso in maniera esplosiva e non di rado autodistruttiva. Come ciclista urbano sperimento quotidianamente il bullismo di molti conducenti di veicoli motorizzati (una delle forme socialmente accettate di sfogo dell’aggressività repressa), ma è un’aggressività che trova come primo bersaglio gli automobilisti stessi.
Il punto è che la società collettiva ci sottopone a pressioni che in contesti diversi e più ‘naturali’ potevano essere alleviate semplicemente allontanandosi dalla fonte del nervosismo e dedicandosi ad altro, anche solo ad una passeggiata. I moderni contesti urbani non offrono più spazi adeguati a ‘sbollire’, col risultato che le pressioni si accumulano con esiti non di rado catastrofici (dagli omicidi/suicidi al femminicidio) nonostante il tanto decantato “benessere”.